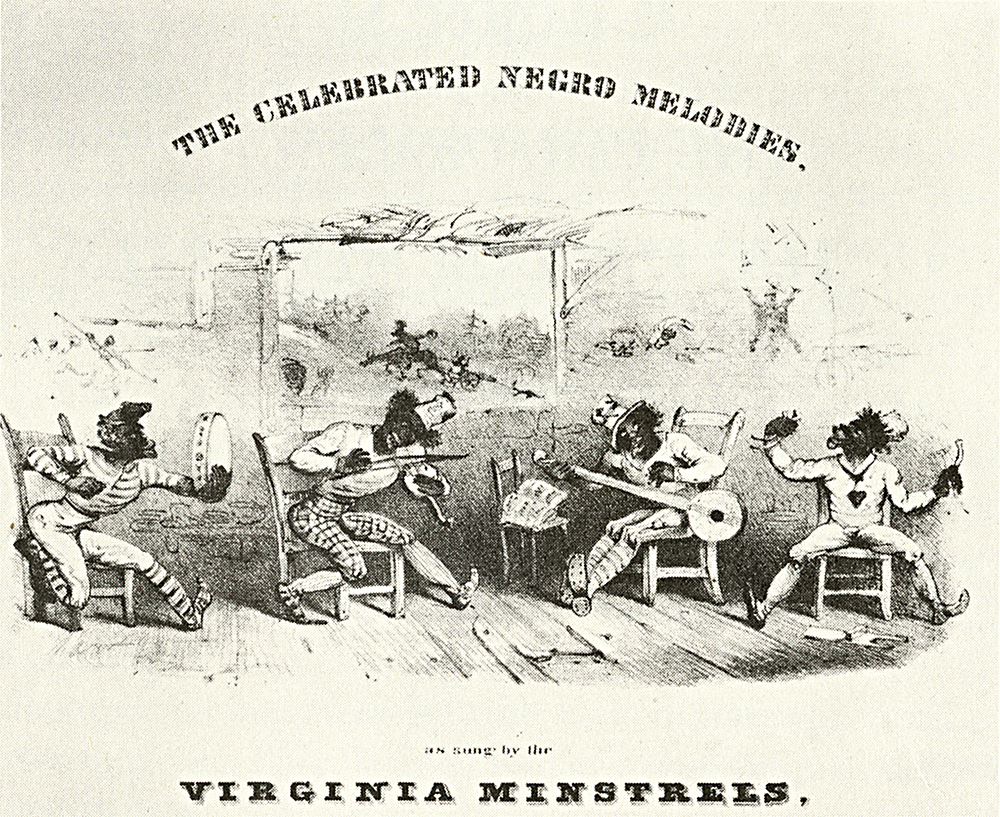Fonte immagine Wikipedia
Il genere Operetta sbarca in America
L’operetta arrivò in America come tutti gli altri generi, ma la curiosità sta nel fatto che la prima rappresentazione avvenne per caso, nel 1867, e a causa del forfait di una attrice, l’italiana Adelaide Ristori.
All’epoca alcuni divi si rifiutavano di andare in scena tutte le sere, ma gli impresari, pur di non perdere pubblico e di sottostare alle stravaganze delle prime donne che con il loro fascino riempivano i teatri, dovevano trovare delle soluzioni.
Fu proprio quello che fece il direttore del French Theatre che, di fronte ad un rifiuto di andare in scena, propose un’altra compagnia con la versione francese di un’operetta di Offenbach intitolata La Grande Duchesse De Gérolstein.
Nonostante l’incomprensione linguistica fu un gran successo e così l’operetta francese/europea sbarcò di diritto in America, fino al 1871 quando furono disponibili le prime versioni tradotte in inglese e la critica visse forti momenti di scalpore a causa di quei contenuti spudorati e frivoli che fino a quel momento non aveva inteso. La condanna a genere volgare e fraintendibile fu pesante, ma il pubblico continuò a apprezzarla insieme ai successi viennesi.
Il successo viennese certamente più amato fu La Vedova Allegra, sbarcato in America nel 1907 due anni dopo la creazione a Vienna e due mesi dopo la trionfale presentazione londinese.
«In meno di un anno circa cento compagnie recitavano e cantavano La Vedova Allegra in giro per il mondo e soprattutto ballavano l’ormai celeberrimo valzer. Grazie all’assenza di leggi sul copyright si erano vendute per mesi e mesi copie e copie della musica di Lehar a cinque cents ciascuna. Per cui c’era stata una diffusione capillare preparatoria tale da far correre il pubblico all’annuncio delle vendita dei biglietti e schierarlo in lunghe file compatte sulla 42a Strada verso il New Amsterdam Theatre. Ci fu, in conseguenza del successo, una moda Vedova Allegra, addirittura intitolando certi cappelli o guanti all’operetta.» A. CHIODI, Musical in Italia, p. 12
Pochi anni prima, nel 1878 conquistarono il mercato americano i due già citati Gilbert & Sullivan, presentando il loro successo H.M.S Pinafore (H.M.S è il nome di un vascello Her Majesty Ship, cioè la nave di Sua Maestà). Il libretto era comprensibile e le canzoni orecchiabili così che il pubblico applaudì divertito e iniziò a comprare gli spartiti per suonarla.
Era questo un nuovo fenomeno che diventò ben presto un grande business per gli Stati Uniti. Il problema alla base era la mancanza di accordi internazionali relativi al diritto d’autore che faceva si che i proventi non arrivassero direttamente agli autori.
Le operette di questa grande coppia godevano di una satira intelligente e di un’unità strutturale che fece scuola. Benché essi non si tollerassero molto e preferissero scrivere per posta con una rara capacità di collaborazione tenendo conto di quest’aspetto, essi erano in grado di mixare influenze musicali svariate e di creare testi ingegnosi con giochi di parole e non-sense difficilmente traducibili in altre lingue.
Gilbert & Sullivan furono i primi di una lunga lista di coppie celebri del musical e del teatro musicale, Rodgers & Hart, Rodgers & Hammerstein II, Lerner & Loewe, Schönberg & Boublil, Webber & Rice e in Italia Garinei & Giovannini.
Dalle operette europee a poco a poco nacquero quelle americane, ma sottolineiamo che gli autori di queste ultime erano europei trasferitisi nella nuova patria. I soggetti vennero ambientati in America, chiaro segnale di un popolo che già con le Ziegfeld Follies voleva affermare la propria identità politica, sociale e artistica. Tre nomi furono importanti per questo punto di passaggio tutto americano: il dublinese Victor Herbert, il boemo Rudolf Friml, e l’ungherese Sigmund Romberg.
Herbert ebbe sicuramente il merito di una produzione musicale prolifica e di troncare l’usanza delle prime donne del tempo di inserire negli spettacoli altri brani estranei alla partitura, introducendo nei contratti una clausola specifica per l’argomento. Riuscì inoltre a fondare, con altri colleghi, l’ASCAP, ovvero l’American Society of Composer and Authors, associazione dedita alla tutele del diritto dei compositori e degli autori, con in alcuni casi addirittura il versamento delle royalties relative ai brani usati da altri a scopo intrattenimento. Fu anche il primo a pubblicizzare un suo spettacolo, The Red Mill (il mulino rosso), in modo professionale, con un totem a forma di mulino con le pale in movimento ed interamente illuminato elettricamente (una delle prime insegne luminose di Broadway) all’ingresso del teatro che lo ospitava. Anche l’impianto sul palco fu elettrico per la prima volta nella storia.
Ad Herbert si deve anche l’introduzione di nuovi ritmi di cui il musical beneficiò, un ritmo sincopato e brillante, il fox-trot amato dalle nuove generazioni, e questo testimonia la sua grande apertura mentale e la disponibilità di attingere da innovazioni inevitabili e moderne.
La sua vita fu celebrata dal musical cinematografico The Great Victor Herbert, nel 1939
Sappiamo dai racconti che Herbert usava litigare spesso con le prime donne dei suoi spettacoli, così nel 1912, proprio a causa di un litigio, entrò in scena Rudolf Friml. Egli scrisse un’operetta The Firefly che la critica applaudì per la bellezza, tollerando il tanto odiato “bis” assolutamente fuori moda fra le platee musicali americane e inglesi.
Finito lo spettacolo, le compagnie inglesi e americane non eseguono il bis, molto in voga invece nel nostro paese al punto che gli artisti che non lo concedono risultano maleducati e criticati duramente così da veder messa in discussione l’intera loro performance. Il sipario rimane aperto e la compagnia esce solo per ricevere gli applausi del pubblico mentre l’orchestra continua a suonare finché la sala non si svuota. Molte compagnie straniere in tour in Italia si adattano alle nostre usanze concedendo la ripetizione di un brano o due.
Con Sigmund Romberg, intorno agli anni ’20 si assistette invece alla vera celebrazione dell’operetta americana. Egli si concentrò sugli aspetti e sull’importanza del book, vale a dire la storia alla base dello show. Romberg codificò un metodo di lavoro che prevedeva il non iniziare a scrivere la partitura prima di avere in mano la stesura completa del testo, per essere il più coerente possibile con la vicenda. Il suo stile prevedeva accostamenti diversi, tanto da inserire nelle sue operette accenni di ragtime e di jazz, che stavano in quell’epoca per conquistare Broadway.
La crisi economica di quegli anni tuttavia segnò un traguardo per l’operetta americana, che rimase un genere per estimatori, lasciando il posto ad una musica che rappresentasse la reazione energica e l’inizio di un nuovo stile di vita per la società americana.
Altri autori diedero voce a queste nuove esigenze e nacque così definitivamente una nuova forma di teatro musicale, più moderna e articolata, che sapesse attingere dal passato e comprendere i generi precedenti, ma anche parlare al futuro con sguardo innovatore: il musical.
Partendo da New York e Broadway, nacque una tradizione di ballerini, cantanti e attori e un modo di fare spettacolo immediato ed entusiasmante che, come vedremo nei prossimi capitoli, si diffuse a macchia d’olio, portando la cultura del musical dalle piccole e grandi città degli Stati Uniti, da Broadway fino ai teatri del West End a Londra, la quale diventò la grande capitale europea di questo genere teatrale, fino a tutte le altre città d’Europa.
Tale fenomeno venne celebrato dalle versioni cinematografiche di Hollywood, che contribuirono notevolmente a far conoscere, a dare popolarità e a divulgare questo nostro genere, creando un vero parallelismo tra spettacolo teatrale e filmico, con reciproca capacità di completarsi e arricchirsi.